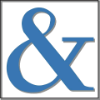Che tutte le culture, e non solamente quelle popolari, pullulino di esseri e di animali fantastici è noto (i versi sopra citati sono tratti dal Detto del Gatto lupesco, un componimento duecentesco in cui un giullare sbruffone si vanta di aver fatto un viaggio avventuroso e cita appunto questi ed altri animali da lui inventati per stupire il suo pubblico) e anche la nostra Lunigiana Storica non è da meno.
In questa puntata della rubrica esamineremo l'aspeosordo, la vacavarièa, il tetavache, la maimuna, l'òmu main, il lupomanàio, l'òmo sarvàdego e il baffardello.
L'aspeosordo, letteralmente "aspro sordo" (ma nei dialetti della zona sono diffusi anche i tipi àspio, aspro, asperosordo), si ritiene a livello popolare sia il maschio della vipera, molto più velenoso della sua consorte. Esistono, ovviamente, vipere maschio e vipere femmina, ma "aspide", secondo gli erpetologi, è un altro nome della "vipera comune" (Vipera aspis secondo Linnaeus, 1758), della famiglia Viperidae, e non identifica il maschio della vipera. Che si tratti di un animale immaginario ce lo conferma Biassa, dove le vipere non sono mai esistite, e che pure annovera nel suo inventario lessicale il termine aspeusurdu. Ma sentiamo Giancarlo Natale: i biasèi i credevu che l'aspeusurdu per andae adaré ae persune i se meteva a cua 'n buca per fae 'n zerciu e regüaghe ciü ṣvèrtu adaré. Insomma, si mordeva la coda per far di sé un cerchio e rotolare a mo' di ruota dietro al malcapitato datosi evidentemente ad una fuga precipitosa. Nell'uso comune del paese di San Martino il termine è poi passato a denotare chi getta discredito sul prossimo senza apparire: èse come 'n aspeusurdu, aveghe a lenga cume 'n aspeusurdu. La tradizione popolare dice che sia sordo, cosa non molto distante dalla realtà; infatti le vipere non sono dotate di un apparato uditivo molto efficiente, tant'è vero che hanno sviluppato degli organi sensoriali particolari che consentono loro di avvertire le vibrazioni del terreno e mettersi in salvo (è notorio che la vipera attacca solo per difendersi se non può scappare) ed è per questo buona norma, che i fungaioli adottano, battere il terreno con un bastone per far allontanare il rettile. Quello di attribuire menomazioni ai rettili è un vezzo comune della mentalità contadina. Pensiamo all'orbeto, o bissa òrba, o bissa da 'n òcio, a Biassa anche bisa ghèrza, ovvero l'"orbettino", Anguis fragilis secondo Linnaeus, 1758, fragile per via della sua facoltà di tagliarsi la coda in caso d'attacco, per lasciarla al predatore e potersi mettere in salvo mentre quello si accanisce sul moncone. Ma il nostro sauro, nonostante il nome di biscia, biscia non è, ma una lucertola priva di zampe, e nonostante l'epiteto di non vedente, cieco non è, ma ha soltanto gli occhi piccoli. E non è neppure velenoso, come invece sostiene la cultura popolare. Visto che siamo in tema di serpenti ricordiamo ancora la bisa rospaa o rataèa, a Biassa rispettivamente ruspaa e rataöa, la seconda forma in uso anche in Val di Vara, mentre alla prima vi corrisponde la biscia bagiaöa, vale a dire il "biacco", o "biscia d'acqua" o "natrice dal collare", perché si nutre di rospi (bagi in Val di Vara) e di topi (rati). Ricordiamo ancóra che da noi la lucertola si chiama léssoa (léṣua, lösciua e lésna rispettivamente a Biassa, in Val di Vara e in Val di Magra), mentre in spezzino il ramarro è lighèo (ligöu a Biassa, ligö̀ o lagö̀ in Val di Vara, ligoro o lesnon in Val di Magra).
La vacavarièa, letteralmente "vacca cangiante", è la "salamandra pezzata" (Salamandra salamandra secondo Linnaeus, 1758), suppostamente velenosa, che fa le sue apparizioni dopo gli acquazzoni. Detta anche, a seconda delle varianti locali, vacavàia, vacave(r)a, vacavarela, vacava(r)ö(l)a. È una parola a diffusione molto circoscritta all'appennino emiliano, l'alta Lunigiana e in alcune valli della Liguria orientale (Val di Vara e Val Graveglia chiavarese). Molto particolare l'uso di "vacca" per denotare un diverso animale molto più piccolo, degno di essere approfondito.
I tetavache, ovvero i "succiacapre" (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) sono uccelli notturni, che la tradizione popolare vuole ghiotti di latte, che andrebbero a succhiare alle vacche o alle capre (tant'è che il loro nome in alcuni dialetti della zona è tetacrave), le quali, dopo essere state violate, diventerebbero sterili o addirittura cieche. C'era chi diceva che andassero a succhiare il latte anche alle puerpere. Niente a che fare, comunque, col chupacabras dell'America Meridionale, che è supposto essere una sorta di cane con degli aculei in testa, molto più temibile del nostro volatile. A Biassa è diventato anche sinonimo di persona asociale che esce solo la notte.
L'òmu main, letteralmente "l'uomo marino", è in realtà la "foca monaca" (Monachus monachus, Hermann, 1779). Sempre da Giancarlo Natale apprendiamo che "alla fine del 1800, quando le cave lavoravano ancora, i cavatori delle cave vicine al mare avevano notato uno strano animale che, nuotando, andava a rifugiarsi nelle grotte. Lo avevano chiamato òmu main per le movenze quasi umane". A meno che i biassei non avessero scambiato per quel pinnipede in via d'estinzione gli incursori del Varignano intenti a fare esercitazioni.
La maimuna di Rio di Sesta Godano è la versione locale del "gatto mammone", creatura magica la cui credenza è diffusa in tutta la penisola e presente nelle fiabe. Il suo nome deriva da un incrocio tra il gatto e la scimmia (in arabo MAIMŪN), mentre secondo alcuni etimologisti deriverebbe dal biblico Mammona, cioè il demonio: "Non potete servire Dio e Mammona" (Isaia 49, 14-15). La tradizione di Rio ci è stata raccontata da Paolo De Nevi il quale, nel volume Val di Vara un grido un canto (Centro Studi Val di Vara, 1988), ci narra che la gita al Gottero era considerata un'iniziazione per gli adolescenti del paese, ai quali era vietata fino al compimento degli 8-10 anni, anche per la presenza della Maimun-a, una vecchia brutta e sporca, alla quale i novizi avrebbero dovuto bajà u cü!. Ovviamente gli anziani e i burloni del paese, a parte l'avvertimento, non fornivano ulteriori particolari, rendendo così ancóra più eccitante l'avventura. Il giorno fatidico della spedizione, dopo una faticosa marcia della durata di circa quattr'ore, finalmente in prossimità della vetta del Gottero i ragazzi, benché stanchi, iniziavano a correre per scoprire il segreto della Maimun-a, e per via dell'erta scoscesa e accidentata finivano tutti invariabilmente con la faccia a terra, al che gli adulti della comitiva, ridendo, sentenziavano: éi bajà u cü a Maimun-a? ("avete baciato il culo a Mammona?"). Qui la Maimun-a incarna la versione "buona" della Mammona, la Madre Terra, o Grande Madre (la Mater Magna latina) cui il contadino doveva - come tutti dovrebbero - rispetto e devozione. La tradizione è riportata anche da Enrico Calzolari, a p. 1737 del III volume dell'opera La letteratura nella Lunigiana Storica, ideata e curata da Giovanni Bilotti, in riferimento al detto serrese basae er cuo aa vècia, pagina alla quale rimando per ulteriori approfondimenti.
Il lupomanàio è il licantropo, popolarmente lupo mannaro, voce di origine meridionale derivante da un supposto mediolatino LUPUS *HOMINARIUS. La forma pontremolese non sembra essere autoctona, in quando ci aspetteremmo una forma come luv manar. Ne consegue che l'introduzione della leggenda sia piuttosto recente. Ci ha tramandato la tradizione il matematico e poeta pontremolese Luigi Poletti nell'omonima poesia, di cui segue il testo. Il Poletti è anche autore dell'inno nazionale pontremolese Al Campanon d' Pontrémal, che è - a quanto ne so - l'unico che possano vantare una città o paese della nostra zona. Per un approfondimento rimando allo studio di Pietro Settimio Pasquali su Lares Vol. 10, n. 3 (giu. 1939), pp. 212-217. Ho adattato leggermente la grafia rispetto al testo originale, avvertendo che la ë si legge come la ö del genovese (eu francese) e la ü come in spezzino.
AL LUPOMANÀJO
Quand l'è 'n ciòchë d'nòta da vèrs San Zümian
a ven di lamënti mèz òmun mèz can
ch'i t'më̀tun an t'l'anma na përa e 'n mistér
che i znuci e la vita tü t'sënt armüsnèr!
I è 'l lüpomanàjo ch'i pass argürlun:
i è 'n manga d'camisa, i è sënsa causun,
i bat dai Surchëti fin suvr'al Piagnar
pr'al fòss e i aldami i s'va rantanar.
I can ch'a zir d'nòta ch'i l'han za burì
(virtǜ d'ancantésmë!) i càpitun li:
cun lü tüt ansémal i trë̀piun e i van
lü i bai cmè 'na bèstia e i pianz cmè 'n cristian.
I gh'ha i cavéi driti e l'òcc tütt asés,
an mèz ala Biédla i pass cmè 'n rodéz,
pr'i pü stanabüsi ch'a s'pòss mai truvèr
pr'i müci d'rümënta lü i s'mët a früghèr.
S'i trëv quarca curta ch'l'è bǜia e sbandà,
a gh'ciap 'na gran smania d'muntèr sü par ca,
e l'è na furtüna che 'l Ciél i abi vsü
che trei scalin suli lü i pòss muntèr sü!.
Se mai quarca nòta t'a'l sënt arivèr,
o 'nfila 'n t'na curta o sërca d'vutèr:
ma s'i t'ha za vistë e i è li ch'i végn,
eh!... të tira avanti però bada bén:
a'n gh'mëtr adòss i òci né dèrghë da mënt,
ma tira ben d'lünghë e fa mustra d'gnënt,
e se t'gh'avëss anca pistòla e bastun
scantuna 'dré i müri, magari an gatun!
Parchë s'i s'acòrzë che t'l'abi guardà,
tü t'pë 'rcmandèr l'anma, par të t'sé spacià!
cun tüt chi bajüchi lü i t'vul a caval
e 'n gh'è pü d'malisia, né fòrsa ch'a val.
I disun ch'i sibi pü fòrt che Sansun,
rabius cmè na tigra, nervus cmè 'n leun,
e che sèrti ürlasi s'an gula i büt fëra,
che të, pòvar diàval, t'mër bén dala përa!
Quand l'è 'n ciòchë d'nòta e t'sëntë d'lüntan
chi brüti lamënti, mèz òmun, mèz can,
artìrt a ca tuga e prima ch'i pass
të stanga la pòrta e dagh al cadnass!
Considerata la notevole difficoltà del dialetto pontremolese per i lettori spezzini, do qui di séguito la traduzione letterale:
[Il lupomannaro - Quando suona la campana di notte verso San Geminiano (parrocchia di Pontremoli, dedicata al santo protettore della città)/ vengono dei lamenti mezzo uomo e mezzo cane/ che ti mettono nell'anima una paura e un mistero/ che i ginocchi e la vita ti senti rimuginare!/ È il lupo mannaro che passa a rotoloni:/ è in maniche di camicia, è senza calzoni,/ batte dai Surchëti fino sopra al Piagnaro/ per il fosso e il letame si va a rintanare./ I cani che girano di notte lo hanno già scovato/ (virtù d'incantensimo!) capitano lì:/ con lui tutti assieme scherzano e vanno/ lui abbaia come una bestia e piange come un cristiano./ Ha i capelli dritti e gli occhi tutti accesi,/ in mezzo alla Biédla passa come un sasso che rotola,/ per i bugigattoli peggiori che possa mai trovare/ per i mucchi di spazzatura si mette a frugare./ Se trova qualche corte che è buia e incustodita,/ gli prende una gran voglia di salire su in casa,/ ed è una fortuna che il Cielo abbia voluto / che possa salire (montare su) solo tre scalini!./ Se mai qualche notte lo senti arrivare,/ o infilati in una corte o cerca di svoltare:/ ma se ti ha già visto ed è lì che viene,/ eh! ... tira dritto però bada bene:/ a non mettergli gli occhi addosso e a non prestargli attenzione,/ ma tira ben di lungo e fai finta di niente,/ e anche se avessi pistola e bastone / scantona dietro ai muri, magari anche carponi!/ Perché se si accorge che l'hai (abbi) guardato,/ ti puoi raccomandare l'anima, perché sei spacciato!/ con tutti quei cani ti si avventa sulle spalle (ti vola a cavallo)/ e non c'è più astuzia (malizia), né forza che valga./ Dicono che sia più forte di Sansone,/ rabbioso come una tigre, nervoso come un leone,/ e che certi urlacci se in gola butta fuori,/ che tu, povero diavolo, muori ben dalla paura!/ Quando suonano le campane di notte e senti da lontano/ quei brutti lamenti, mezzo uomo e mezzo cane/ ritirati a casa tua e prima che passa / spranga la porta e mettici il chiavistello!/.]
Un'altra credenza popolare, che ci ricorda lontanamente il big foot o l'abominevole uomo delle nevi, era quella dell'òmo sarvàdego (in versione più moderna ed edulcorata l'òmo der bòsco), che avrebbe insegnato a fare il formaggio e la ricotta agli abitanti di Vinca, che poi l'avrebbero ucciso. Vinca sarebbe stata fondata dai profughi di Luni che, dopo la distruzione della città, si erano inizialmente rifugiati sul monte Sagro. Accenna alla leggenda il Viandante, Carlo Caselli, nel suo Lunigiana Ignota, a p. 131. Con maggiore dovizia di particolari ne parla Augusto Cesare Ambrosi in La Spezia. Rivista del Comune. A. 1956 (numero unico), pp. 58-62, il quale ci dice che a Casola (il suo paese natale) si era soliti dire: a sian com l'om servatig; quand piò i va a laorar e quand a tir vent i sta n ca. La leggenda è nota in gran parte della Lunigiana, ma non a Pontremoli, dove appare invece la figura dei sarasin, gente di bassa statura, la cui descrizione ricorda il fenotipo degli antichi Liguri. Il nome sarasin sarebbe dovuto all'influenza dei pirati saraceni, con una confusione di epoche. Non poteva mancare un accenno "alla sua maniera" da parte del nostro Gamin il quale, nel III sonetto del poemetto A passion do Signoe, racconta così le tentazioni del diavolo durante i quaranta giorni di digiuno di Gesù nel deserto:
Ma 'r bèo l'è quando 'n giorno i dezünava
En sima a 'n monte de quei posti la,
Che dòpo tanti giorni ch'i pregava
Ghe vènse 'n mente ch'i n'avea mangià.
Ècheve che o Diao ch'i rondezava
Apòsta per quei siti, e i s'ea ciatà
De daré da na sèza, e i aspetava,
I sortì fea, e i ghe fe: - Dizé a veità.
Avé apetito? e comandé a 'sto sasso
Ch'i deventa michete, s'a se bon! -.
E lü: - L'òmo i ne canpa, Satanasso,
Solo de pan; ghe vè anca 'r conpanàdego!
Se sa: sensa 'n litreto e 'n menestron
N'è bon manco a canpae l'òmo sarvàdego -.
Ma sicuramente la tradizione più caratteristica della Val di Magra è quella del baffardello (in dialetto bafardel o bufardel), il folletto, un omino tutto vestito di rosso che di notte s'infila nelle stalle a fare i dispetti o le gentilezze alle mucche e ai cavalli, come ci racconta con dovizia di particolari Egisto Veschi in questa poesia in dialetto di Villafranca. Il nome è probabilmente legato al concetto di "beffa", o di "baffo", o di "buffare"
AL BUFARDÈL
Quand ala sera a cmincia a far nòta
e t' senti ch'a sona l'Ave Maria,
arduna la bèstia sot'ala vòta,
pò fa la conta e prima ad gnir via
arbata la pòrta, archjuda al zapèl
e guarda ch'a n' ch'sìbia entrà 'l bufardèl.
Al bufardèl i ven fit a stralanci
pena ven nòta, cm' a fa i slandridi,
i entra ant' la stàlia da tut i busanchi,
i urla, i rida, i manda di stridi,
e, s'i s'aràbia, cme tut i ragazi,
i t' fa i dispèti e i malatazi.
S'i trova na manza ch' l'è zovn e bèla,
la basa, la leca, i la careza,
i gh' da al fen magengu o l'erborèla,
an fond a la coga i gh' fa na treza;
e quand a ven di i s' loga ant'al biàdal:
i è spirit, i è bèstia, i è 'l fiol dal diaval!.
S'i trova na vaca ch'l'è vèchja, scagnà,
la pista, la liga, stret la cadena,
t'la trovi al'arba ch' la s'è stravozà,
che, pòvra bèstia, la respir apena;
ma se ant' la stala a gh'è Sant'Antòni,
la palma, l'oliva, i scapa 'l demòni.
I disan ch'la sìbian tuta credénzia
ch'la gh'évan na vòta la nòstra géntia,
anveza l'è vera, l'è pròpi vrità,
... cme 'n asan ch'a vola o 'n usèl ch'ha ciuchjà!.
[Il Baffardello - Quando alla sera comincia a far notte/ e senti che suona l'Avemaria/ raduna le bestie sotto alla volta (nella stalla),/ poi contale e prima di venir via/ ribatti la porta e chiudi la staccionata / e guarda che non sia entrato il Baffardello.// Il Baffardello arriva sùbito con dei gran salti/ appena viene notte, come fanno gli sbandati,/ entra nelle stalle da tutti i buchi,/ urla, ride, fa degli stridi/ e, se s'arrabbia, come tutti i ragazzi,/ ti fa i dispetti e le malefatte.// Se trova una manza che è giovane e bella,/ la bacia, la lecca, l'accarezza,/ le dà il fieno maggengo e l'erbetta,/ in fondo alla coda le fa una treccia;// e quando fa giorno si nasconde nella gora:/ è spirito, è bestia, e figlio del diavolo.// Se trova una vacca ch'è vecchia e macilenta/ la picchia, la lega stretta alla catena,/ la trovi all'alba con gli occhi strabuzzati,/ che, povera bestia, respira appena;/ ma se nella stalla c'è (l'immagine di) Sant'Antonio, la palma e l'olivo (benedetti),/ scappa il demonio.// Dicono che siano tutte credenze/ che aveva una volta la nostra gente,/ invece è vero, è proprio la verità,/ ... come un asino che vola o un uccello che ha succhiato! (il succiacapre).//
La tradizione del baffardello è simile quella dello strego della Garfagnana e del linchetto della Valle del Serchio, ma a quanto ne so non è presente né alla Spezia né in Val di Vara. E per vero, nella tradizione folclorica spezzina le streghe non compaiono spesso, tant'è che il famoso Saggio di folclore spezzino di Ubaldo Mazzini attesta solamente questo distico: La cèva e l'amia o so, /Tüte e strie i fan l'amò che, al di là delle esigenze di rima, tradisce un'origine esotica con quell'amò che ricorda l'amù della Val di Vara, dove giustamente rima con su ("sole").
Chiudo questo excursus parlando dell'asino (ase in spezzino e in Val di Vara, asno, asen, asu in Val di Magra). In spezzino (e in biasseo) si chiama anche borico (termine diffuso in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e in Francia, da BURRICUS "cavallino") e - più genericamente - er bèstio, in particolare nell'espressione aveghe er vìssio der bèstio, cioè "intestardirsi a non voler fare qualcosa". Ma c'è un'altra espressione il cui significato dev'essere sfatato, ovvero 'gnoante come l'ase, che non ci deve trarre in inganno facendoci pensare alle orecchie d'asino di Pinocchio, né al cappello da asino che dovevano indossare un tempo a scuola i ragazzi negligenti dietro alla lavagna (brutto retaggio dell'inquisizione spagnola). Da noi ignoante riferito all'asino non ha a che fare con l'istruzione, ma con la maleducazione, e l'asino è "ignorante" perché maleducatamente non si pèrita di esibire le sue virtù in pubblico nel momento meno opportuno. E nemmeno sa apprezzare le cose raffinate, tant'è che per dire che una cosa è sprecata per una certa persona si afferma: l'è come dae di fenoceti - cioè gli "anicini" - al'ase.
Ad Arcola due sono gli asini diventati famosi, ovverosia l'ase de Guarnèlo e l'ase de Pacechin. Il primo è pietra di paragone di chi ha molti difetti o molti acciacchi: te gh'è pu defèti del'asen de Guarnèlo (ch'i 'n ava trentadoi solo soto aa coa), mentre l'altro, che se ne stava comodamente affacciato alla finestra della casa del suo padrone, è stato reso celebre da un bel sonetto di Livio Gianolla, scomparso prematuramente, secondo me il migliore dei poeti dialettali della Lunigiana Storica. Gli lascio la parola, naturalmente in dialetto arcolano, avvertendo che il "profumo de Cotì" fa riferimento alla celebre canzone Balocchi e profumi:
U TOSCANO E L'ÀSEN DE PACECHIN
Tuti i pèisi ch'i gh'han pu antighità
gi-èn fati come 'r filo d'en giumèlo
che partindo daa Tore o dar Castèlo
i se desvògia 'n zìrcoli de ca.
E Àrcoa l'è au listesso ma a quei di
gh'ea pu bèsti per pèise che cristian:
ognun i gh'ava a stala soto man:
fegùete che profumo de cotì!
Mo vien che 'n giorno a vende ia spazadoa
la càpeda 'n luchese d'atrà i Pià
e i scòrẓa ar Portèlo, 'nsù, snaià
l'àsen de Pacechin coa tèsta foa
daa fenestrèla spalancà, e u toscano,
i s'è sfregà bien gi-òci, i l'ha armià,
pò i fa - Maremma bua che ho da guardà!
Un asino, ar balcone al quinto piano! -
Questi i link delle due puntate precedenti della nostra rubrica:
Quando si parlava sprugolino 1)
Quando si parlava sprugolino 2)
Quando si parlava sprugolino 3)
Quando si parlava sprugolino 4)