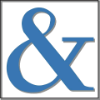Giordano Giannini, classe ‘87, laureato con lode in Storia e Forme delle Arti Visive, dello Spettacolo e dei Nuovi Media all’Università di Pisa. Da anni, tra Liguria e Toscana, tiene corsi di lettura filmica presso scuole di vario grado, sale d’essai e associazioni di promozione sociale. È membro attivo dell’Accademia fiorentina “Aliprandi-Rodríguez” (Multimedialità della Scrittura e della Comunicazione) della quale cura la sezione “Cinema & Audiovisivi” e relative videoconferenze. Fra le pubblicazioni: prefazione al saggio-testimonianza “Il riscatto. Le esperienze di un giovane che incontrò e non tradì le profezie di don Lorenzo Milani” di Alessandro Mazzerelli (If Press, 2022); “Buffy non deve morire. Adolescenti, Mito e Fantastico nei Nuovi Media” (Città del Sole, 2020; insieme a Nicoletta Gruppi); “Cinema e giardini. Una lettura iconologica” (Pontecorboli, 2016).
Giannini, nella sua carriera professionale si legge che da anni tra la Liguria e la Toscana lei porta avanti corsi di lettura filmica presso scuole di vario grado. La sua attività in cosa consiste?
Invitare alla scoperta di un “testo cinematografico” per poi commentarlo, a incontro concluso, insieme ai presenti, cogliendone i sottotesti, piccoli dettagli, ascoltando le riflessioni che gli spettatori condividono, le impressioni (anche negative) che la visione ha lasciato loro. Almeno in parte sono stato influenzato dalla lettura di un saggio collettivo, TerrAcqua (Mimesis; 2007), nel quale si sottoponevano le opere di nove grandi registi (tra cui Franco Piavoli) a ciò che il prof. Paolo Mottana chiamò “esercizio immaginale” ossia lo sforzo di ridestare quello sguardo pregno di stupore di cui godevamo nell’infanzia, cercando di entrare davvero in contatto con l’opera osservata, con quello che di fatto “mostra” e “dice” evitando, quindi, di imprigionarla in una formula, di supplire alla carenza di sensibilità con un “fuoco d’artificio” di cultura e ingannevoli rimandi. Metodo tutt’altro che facile ma in cui credo ostinandomi, con personali varianti, ad applicarlo. Lo spirito giocoso con cui mi approccio rimane (e spero rimanga) lo stesso.
Lei quindi per la sua attività è a contatto con generazioni diverse di studenti. Quali sono le caratteristiche che ha colto? C’è un tratto distintivo che emerge in maniera netta?
Non ho abbastanza esperienza da trarre conclusioni. E anche se l’avessi maturata, la mia risposta suonerebbe comunque inetta poiché ogni percorso di studi, classe o alunno costituisce un microcosmo a sé. Non esistono dinamiche realmente ricorrenti o generalizzabili a meno che il tratto distintivo, oggigiorno, non sia proprio questo cioè l’imprevedibile eterogeneità dei singoli casi che richiede all’educatore una lucidità costante e la disponibilità a sperimentare, osservando. Potrei giusto abbozzare un’ipotesi. Negli adolescenti con cui mi sono confrontato si percepiva chiaramente la paura della fine, del limite. Ciò li accomuna a genitori e nonni. Tutte e tre le generazioni, ormai, esorcizzano tale timore non attraverso il giudizio, la fede religiosa o semplicemente l’immaginazione bensì con l’aiuto di surrogati che, con la loro lunghezza, offrano ora dopo ora, con calore quasi famigliare, l’impressione di un’inscalfibile continuità, perfino di conquista di una fetta di “immortalità” nel godimento del racconto: da qui, a mio avviso, il successo della serialità (nulla di strano: il cinema nacque così), nelle immagini come nella letteratura di consumo. Non scorderò mai lo scambio avuto con una studentessa: «Ti piace vedere i film?» – «Si. Certi, poi, mi fanno impazzire! Preferisco le serie, però» – «Sapresti dirmi il perché?» – «I film mi mettono tristezza, non importa di che parlano. Finiscono tutti e ci rimango male. Le serie invece no» – «Beh, anche una serie si conclude» – «Può finire la serie ma non i personaggi. Non so come dire. Li ho conosciuti bene, li ho amati, so che ci sono e proseguono la loro storia, le loro vite anche quando non li vedo più». È un panorama cangiante, dal quale si ha tutto da imparare.
Con una sintesi giornalistica si potrebbe dire che lei si occupa di cinema. Studia e diffonde anche la cultura della lettura filmica. Le nuove piattaforme di streaming sono una normale evoluzione o rappresentano un punto di rottura, un fattore inconciliabile con il mondo del cinema inteso nella sua essenza?
L’avvento delle piattaforme non è da considerarsi un punto di rottura bensì la goccia che ha fatto traboccare un vaso vacillante già dalle prime fasi della sua fabbricazione. I fratelli Lumière lo intuirono e non furono presi sul serio. Il cinematografo esiste da poco più di un secolo: poco se considerato nella totalità della storia umana. Con buona pace degli esperti, esso non si è mai realmente consolidato come esperienza sociale condivisa, a differenza della Musica o del Teatro i quali, infatti, celebrano ora un timido ma avvertibile “risveglio”. Dal cinematografo è scaturita e tutt’ora, qualche volta, scaturisce l’Arte (geni totali come Epstein, Dreyer, Kurosawa, Powell & Pressburger, Tarkovskij lo provano) ma in sé stesso, a ben vedere, non è Arte nell’accezione tradizionale del termine. É un’invenzione “figlia” della seconda rivoluzione industriale e del progresso segue inesorabilmente il flusso, mutando. In tal senso le piattaforme segnano un’evoluzione, inevitabile direi più che “normale”. È illusorio sperare che l’esperienza audiovisiva rimanga protetta dal “buio amico” dei cineclub ancora a lungo. Lo vorrei tanto, difendo e frequento la sala ma so anche che i desideri non cambiano le cose. Il primo, più importante scopo per chi oggi educa alla lettura filmica è aiutare ad acquisire, passo per passo, la consapevolezza dello sguardo così da riconoscere il valore di un’opera, sia che se ne fruisca al cinema, alla televisione, sullo smartphone o davanti al pc. Non ultimo, lottare nel proprio piccolo affinché le case produttrici non facciano mai cadere in disuso i supporti fisici di memoria, blu-ray o altro non importa. Quando non si avrà più fra le mani un oggetto, qualcosa da toccare, curare, collezionare, utilizzare agevolmente ma soltanto una “marmellata digitale” si andrà incontro ad amarissime sorprese!
La commercializzazione dei film o delle serie, con la prepotente crescita e affermazione delle piattaforme di streaming durante la pandemia, ha segnato un punto di non ritorno o ci sarà una fase di assestamento con un nuovo equilibrio?
Propendo per l’ultima. Da un lato resta intatto il bisogno, a diciassette come a settant’anni, di abbandonarsi a piccole storie “umane”, autentiche, ben raccontate (si guardino i recenti successi di All we imagine as light e Il ragazzo dai pantaloni rosa) che ci facciano disintossicare da tante banalità. Dall’altro, un nuovo equilibrio si sta già creando per il semplice fatto che è il linguaggio audiovisivo in sé, del cinema come delle serie, che il pubblico, a mano a mano, impercettibilmente sta disertando. È questo il lascito più rilevante della pandemia: aver ridestato, con intensità diversa, nelle persone la coscienza della virtualità nella quale erano immerse le loro vite, ben prima dell’emergenza sanitaria. Adesso credo che il pubblico desideri, sopra ogni cosa, “uscire”. Non l’ha ancora fatto del tutto. Incontrarsi, “toccare con mano”, avvicinare il proprio corpo a un altro corpo, vincere la solitudine: stanno diventando altri i luoghi, le circostanze, le forme espressive che rispondono a tali esigenze. Il Teatro, come accennai prima, è una queste.
In questo editoriale è stato scritto che “andare al cinema” rappresenta una forma di disciplina: si sta in sala e si è obbligati a tenere alta la soglia di attenzione restando in (religioso?) silenzio. Un esercizio collettivo. Si trova d’accordo con quanto è stato scritto?
Dipende dal film, è ovvio. Quando si guarda 2001: Odissea nello spazio o Sussurri e grida di Bergman contegno e silenzio sono auspicabili oltre che necessari. Viceversa, Evil Dead Rise o King Kong vs Godzilla possono benissimo suscitare reazioni ilari, scomposte come hanno suscitato in me. Ci mancherebbe altro. Il cinematografo ha origine dalle fiere di paese, dai numeri dei fantasisti, dalle case di piacere perfino. E un eco di quei mondi giunge sempre, non bisogna mai zittirlo. Bisogna divertirsi. E, nel mentre, imparare. Le due cose non confliggono. Se lo sguardo è consapevole, ripeto. E deve esserlo. È essenziale.
Quindi è il cinema che rappresenta la società o è la società che rappresenta il cinema? Chi muove chi nella costruzione di questo processo? C’è qualcosa che muove qualcuno o è un processo intrecciato che non fa emergere obbligatoriamente un fattore scatenante?
Ricordo Alberto Arbasino quando provocò Monicelli in una puntata di “Match”: «[…] Ha detto in molte interviste che la commedia ha portato alla maturazione politica e di costume degli italiani. Rovesciamo un po’: non sarà che ad un certo punto gli italiani, vedendo i loro vizi, i loro difetti rappresentati con delle regie così straordinarie e delle interpretazioni così portentose si compiacciano nell’imitarli poiché rappresentati con tanta efficacia?». È una questione annosa. Per prudenza, risponderei che si tratta di un processo intrecciato. Tuttavia ricordo anche ciò che disse Pasolini: «In tutto il mondo ciò che viene dall’alto è più forte di ciò che si vuole dal basso». Ciò include spesso anche il cinema. Un certo cinema. Film come L’ultimo bacio di Muccino e Caterina va in città di Virzì hanno influenzato gli spettatori, inquinandone gli occhi e i cuori assai più di quarant’anni di cinepanettoni e televisione generalista. E mi assumo la responsabilità di quanto affermo.
La sua professionalità certifica uno studio approfondito su quella che è la filologia alla base del cinema. Siamo dentro una semantica narrativa decadente o questo nuovo millennio può ancora dire qualcosa al vecchio secolo?
Il primo ventennio del Duemila si è caratterizzato (in più occasioni, con insistenza, l’ho sostenuto) per l’anelito, espresso per molteplici vie, di ricongiungersi ai primordi, ai briosi diversivi di fine Ottocento (che si sarebbero poi evoluti nella “creatura” dei fratelli Lumière) perché fungano da “segni”, debitamente reinterpretabili, sul cammino che porterà alla filmografia di domani, ancora totalmente da vedersi. Siamo ancora nel Ventesimo Secolo, da un certo punto vista: ciò a cui stiamo assistendo è il suo lungo “titolo di coda”. Non è, dunque, una semantica decadente bensì in incessante metamorfosi, di ciò se ne occupa una disciplina che in Italia non ha ancora messo radici sufficientemente profonde in ambito accademico: l’Archeologia dei Media. Consiglio, a proposito, una lettura godibilissima: Elementi di schermologia (Kaiak; 2014) del finlandese Erkki Huhtamo.