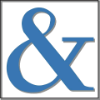Prima di andare ci si prepara. Il bagno, il massaggio, la sauna. Il silenzio. Il pensiero fermo. Le frustate leggere con i ramoscelli di betulla. Si fa così quando si parte per il tempo lungo di un viaggio, se non si è sicuri di arrivare e di ritornare.
Il professore dell’Università di Gorizia ogni volta che ritornava in Repubblica Ceca in macchina preparava il corpo il giorno prima. Durante l’inverno la strada è ghiacciata, la neve imbianca la vista. Lo studente non ha dimenticato il racconto del professore. Ieri sera si è preparato come se dovesse andare alla morte. Ha preparato i vestiti, ha stirato la camicia, i pantaloni, la giacca. Lo ha fatto con un ferro da stiro moderno. In Ucraina lo avrebbe fatto sua nonna per lui, con un ferro scaldato sul ripiano rovente anche in estate della stufa a legna della cucina.
La fabbrica è lontana dalla città. Ci si arriva a piedi.
La pelle del viso è viscida. Gli angoli della bocca non trattengono la saliva. La pupilla pulsa fuori dall’iride. Con lo stesso ritmo del cuore che gli batte in gola. La camicia bianca è bagnata di sudore. Completamente madida sulla schiena, fino alle braccia. Scivola via dalla cintura.
Lo sguardo sbarrato, a tratti ceruleo.
Un braccio piegato, il gomito in avanti, trattiene una giacca spiegazzata. La donna deve scegliere un candidato per l’ufficio commerciale, per i rapporti con i Paesi dell’est. Il giovane uomo non è presentabile, neanche al gruppo di lavoro interno all’ufficio. Lo osserva da lontano mentre lui sistema gli abiti nella sala d’attesa, ignaro di essere in onda nel circuito interno delle telecamere. Ha studiato una presentazione in lingua italiana.
Ieri era agitato. Respirava a fatica. Parla poco e male la lingua. La selezionatrice dell’agenzia lo ha mandato allo sbaraglio al colloquio solo per la conoscenza del russo. E perché non aveva altri candidati. E’ in Italia con una borsa di studio per un anno: un posto letto e pochi soldi per mangiare. Viene dalla campagna. Vive con sua nonna, verso il confine con l’Ungheria. Durante gli studi viveva a Leopoli. Non sempre al sabato e alla domenica ritornava in campagna. Gli manca molto la campagna, lo spazio sterminato che si estende dietro la casa. La casa è piccola e bellissima. Ha il bagno all’esterno. Ma è sempre calda e accogliente. Da nessuna parte dorme profondamente come nella casa di sua nonna.
Si china e assesta un calzino. La donna esce dalla retrovia. Lo ha osservato a sufficienza. Il giovane uomo alza gli occhi con la testa immersa nel verde. Il cuore ha smesso di battere forte. La donna ora vede un ragazzo con gli occhi aperti come la pianura. Si siede. Sono arrivato a piedi, le dice lui. A piedi per un lungo tratto di tangenziale perché con l’autobus sarei arrivato in ritardo.
Lei osserva le labbra incespicare nelle parole. In inglese è più facile. Lui scivola leggero sulla lingua d’appoggio. Racconta la sua condizione di studente e dice di non potere lavorare più di quattro ore al giorno con quel tipo di documento. Lei rilancia sul tipo di lavoro. La lingua russa, mantenere i contatti con le aziende, con gli interlocutori dei Paesi dell’est. In russo. Dall’inglese, sale gli scalini del russo. E’ la mia lingua. Tutti in Ucraina lo parliamo. I Paesi dell’est, Ucraina e Russia e Transnistria e Moldova, sono la mia casa. Il mio spazio vitale.
Il silenzio, lo spazio interminato, il ritmo del tempo, il rapporto stretto tra la vita e la morte.
L’est è la mia Patria.
L’est è un luogo mentale.
La camicia ha ripreso vigore sui muscoli delle braccia e del collo. La memoria del ferro da stiro restituisce vigore al tessuto.
La donna ha deciso. Lo accompagna negli uffici. Gli presenta i colleghi. Gli parla di stipendio, di orario di lavoro. Del contratto. Del lavoro.
In un lampo vede il verde, la casa, il cielo vicino alla terra. L’Ucraina è vicina.
La memoria del corpo lo riporta al pavimento dell’ultima fermata. Dove ha dormito prima di ripartire. Prima di sedersi sul sedile duro del treno che lo ha portato in Europa. Non era l’ultima fermata.
Il lungo viaggio è cominciato. E non è di sola andata. Vitaly, Ucraina. Da uno stabilimento che commercia acciaio, 2005.
Alle cinque del mattino ci scambiamo il letto, un amico ed io. Veniamo dallo stesso Paese. Ci siamo conosciuti al fiume, quando dormivamo nei cartoni dopo avere ritirato il permesso di soggiorno. Io arrivo e lui se ne va. Il letto è ancora caldo. Lui lavora di notte in un magazzino. Da oggi lo affittiamo a una terza persona, per una somma doppia.
Domani per me è il primo giorno di lavoro. Comincio alle cinque. Meglio dormire vicino alla fabbrica. Non voglio arrivare tardi. Gli africani sono sempre in ritardo. L’Africa ha una velocità diversa: zoppica, non corre. Io vengo da un’altra parte del mondo. Non voglio confondermi con gli altri migranti. Sono arrivato dal nord, attraverso la terra ferma. Ho camminato a lungo e mi sono nascosto dentro e sotto i container dei camion. La stazione è un posto sicuro. In Friuli, in una città all’interno, mi sono ritirato vicino al treno. Alla polizia ferroviaria, per una volta ho detto di essere appena arrivato. Altre volte, stavo per partire. Mi è capitato di salire sul treno e di scendere una porta più là. Una volta e due e tre volte e sono diventato riconoscibile. Mi sono avvicinato alla biglietteria. Ho chiesto un biglietto per l’Emilia Romagna. Forse quello era l’ultimo uomo delle biglietterie ferroviarie in Italia. Ha sgranato gli occhi e mi ha detto: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli? Ho detto: Parma. Perché era più o meno al centro dell’elenco. Una parola di poche lettere, la più facile da dire. Ma io non volevo andare a Parma. Volevo rimanere a Udine. Alla stazione dei treni.
Questa volta ho deciso di dormire alla stazione ferroviaria, per lavoro. Questa è piccola e sicura. Dopo una certa ora non passa nessuno. Mi porto la bicicletta. Una pedalata di trenta minuti e sono arrivato. Hanno tolto le panchine di legno con la seduta arrotondata e hanno messo sedili di plastica. Non so se le ho viste anche io le panchine vecchie oppure se me lo abbia raccontato qualcuno, ritornato dopo una lunga permanenza in Italia, qualcuno di stanza sotto il ponte, vicino al fiume. Le pareti sono pulite. Agli angoli e in alto, ci sono i monitor con gli orari degli arrivi e delle partenze. Sul pavimento, un vecchio uomo italiano si lamenta per il freddo e per la luce. Snocciola una litania senza fine per le panchine di legno che non ci sono più. La stazione è nuova e sembrano non esserci presenze umane in divisa, ferrovieri o polizia. Mi accuccio su due sedie, con lo zaino sotto la testa e la bicicletta appoggiata a un braccio di distanza. L’annuncio e la partenza dei treni rompe il silenzio della notte, illuminata a giorno. Domani, comincio un nuovo lavoro di pulizie per tre ore dalle cinque alle otto del mattino, dal sabato al sabato. Alla domenica non si lavora. Un connazionale mi ha presentato al capo per cinquanta euro. Si paga tutto, qui come al mio Paese. Paghiamo anche le informazioni ai fratelli. Per il lavoro. Ma non lo diciamo. E’ normale. Mi hanno fatto un contratto di lavoro immediatamente. Sono poche ore alla settimana, ma chiamano al telefono per chiedere di lavorare di più e pagano tutto. Bisogna rispondere, sempre e subito. Altrimenti chiamano un altro. E non ti telefonano più. E rimani con lo stipendio di poche ore di lavoro alla settimana. E non è più possibile affittare il letto. Il barbone italiano parla in continuazione. Non ho altri posti per dormire. Fuori fa freddo in inverno. Verso le cinque il trillo del telefono mi sveglia dal sonno mai calato dal cielo. Ho le ossa rotte e penso al letto del mio amico. Lui lo lascia libero adesso per il nostro inquilino. La giornata di oggi per me vale quasi uno stipendio doppio: uno lo guadagno in fabbrica e un altro per l’affitto del letto. Mi alzo dalle sedie. Il vecchio si è addormentato e borbotta durante il sonno. Fuori dalla porta a vetri, ci sono due poliziotti sul marciapiede vicino ai binari. Ci hanno visto ma non sono entrati. Un treno è arrivato e una persona cammina lenta verso le scale del sottopassaggio. Infilo la felpa e la giacca e il gilet giallo che mi ha dato il mio amico. Anche lui di notte va alla fabbrica in bicicletta. Sei nero e la notte è nera e nel buio si diventa invisibili. Il gilet catarifragente buca il buio. Piove. La bicicletta scivola via sulla strada bagnata senza fatica. Entro nel tran tran della produzione. Si marcia sempre. Anche di notte. La fabbrica rimanda in sottofondo il brusio ovattato delle macchine. Indosso i pantaloni, la giacca impermeabile e gli stivali di gomma. La lancia è pesante, il getto d’acqua fa rimbalzare il corpo all’indietro. Non pensavo che l’acqua avesse tanta forza.
Mi ritornano in mente i colpi dei talebani sulla schiena. E i racconti degli africani della Libia.
La lancia non è niente rispetto ai bastoni.
Alla paura non ci si abitua. Alla fatica, sì.
Ho sonno. Non si dorme prima di un combattimento. E il lavoro lo è.
Non sentirò la litania del vecchio italiano, la prossima notte. Dormirò.
Il lavoro rende guerrieri. Il sonno del guerriero è un galantuomo. Zadran, Afghanistan. Da una stazione ferroviaria della provincia di Parma, 2017.