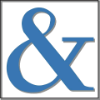Vivo fuori. Non dormo dove capita.
Vivo senza muri intorno. Nella imprevedibile libertà del tempo meteorologico.
Il buio è un coperchio definitivo. A forma di cubo. Dove la mente ritorna, con le tempia compresse tra le ginocchia serrate, i polsi legati dietro la schiena.
Devo vedere uno spiraglio durante la notte. Per respirare. Una stella cadente che graffia il cielo nero. Una pennellata di luce scivolosa sull’asfalto. Incerti fari in lontananza.
Ho più di una dimora. Strade, ponti, porti. I luoghi hanno una loro identità: protettivi alcuni; infidi, altri. Dipende da cosa hanno visto. E con che cosa gli esseri umani li hanno impregnati. Sangue oppure adrenalina. Pensieri in fiore oppure rifiuti.
Io sono la mappa vivente della città. E’ una parte del mio lavoro.
Da qualche giorno è arrivato uno nuovo, vicino al parchimetro della stazione. Un burattino piccolo di statura, spalle strette e gambe magre, una buffa pancia rotonda, labbra carnose stampate su una faccia da bambino con lo sguardo fisso. Al lobo dell’orecchio sinistro un cerchietto di ordinario metallo. Cammina con la schiena rigida e le gambe leggermente divaricate, tiene le mani nelle tasche di una camicia a quadrettoni di flanella pesante. Lo sguardo puntato al futuro, senza vederlo. Una bocca in più per la fabbrica.
La fabbrica della strada.
Non ha chiesto né coperte né cibo. Si aggira guardingo per parcheggi, panchine e incroci. Osserva gli interni delle automobili. Non ha fame. Mangia alla Caritas.
Fa il giro dei parchimetri. E’ riposato. Uno del gruppo della stazione lo ha incontrato nel parcheggio di un supermercato di periferia. In piedi, fermo, si atteggiava a guardiano. Ha osservato con attenzione un nigeriano prendere con destrezza uno zaino dal sedile di una macchina dopo avere aperto la portiera con il jammer. L’automobilista era impegnata a riportare il carrello. E’ ripartita senza accorgersi del furto. Osserva le prede, i portatori di somme di denaro entrare con i cestelli nel supermercato. Guarda. Impara. Dopo il letto, il cibo, le inutili parole e il tetto dell’accoglienza: questo è il presente.
Ciò che rimane delle aspettative sovraccaricate di falsi miti. Della famiglia.
Lui, per loro, è un investimento. Non sanno che è a fondo perduto. Hanno speso soldi per farlo partire, per i documenti, per il viaggio, per i contatti in Italia, quelli che gli diranno come entrare nel circuito dell’assistenza dello Stato. Lavoro o assistenza è uguale: soldi. Che deve inviare subito. Li ha spediti tutti. Lui ha chiesto il lavoro a tempo indeterminato come guardiano con uno stipendio alto. Perché per lui non rimane niente, dopo avere trasferito il denaro alla famiglia. Gli assistenti sociali gli hanno proposto un tirocinio per poche centinaia di euro al mese. Ha rifiutato, ha scritto mille messaggi agli operatori, ha continuato a telefonare, a chiedere. Una fissazione. Il medico gli ha dato medicine, ha cominciato a fargli una puntura ogni mese. Ti paghiamo il biglietto per tornare a casa tua, gli ha detto. Lui non vuole, non se ne va.
Qualche volta dorme su una macchina aperta perché la serratura non funziona. E’ parcheggiata nel piazzale di fronte alla polizia stradale. Il proprietario lo sa che di notte la sua macchina è il giaciglio di qualcuno. Fanno male le ossa e fa freddo nello spazio stretto dei sedili. Ma dentro non piove quando piove.
Noi lo osserviamo. Lui deve dare qualcosa al gruppo se vuole sicurezza e aiuto. Un quadrato di asfalto protetto da un muro, una porzione di terra sotto l’arcata di un ponte sul fiume in secca, una tenda in inverno. Oppure sapere dove andare se ti cerca la polizia, avere un posto per dormire se vuoi stare da solo.
Le strade sono piene di gente di notte. E fredde di gelo anche in estate.
Io sono la guida dei disperati di strada. E’ il mio lavoro. Da quando il capo mi ha detto: ragazzo, il lavoro è finito anche per me.
Il capo era un uomo vecchio anche da giovane. Veniva a prendermi ogni giorno alla fermata del pullman. Quaranta chilometri dalla città fino alla sua officina. La fermata del pullman è vicino al ponte, un crocevia importante: acqua limpida di sotto e di sopra un bar trasformato in discoteca al sabato notte. Aveva una piccola fabbrica di mattoni costruita vicino alla sua casa. Un cubo aperto. Perché io non posso stare dentro un cubo chiuso. E’ stata la prima cosa che gli ho detto nel mio italiano pasticciato. Ma quel cubo di lavoro era sempre aperto e fuori c’erano gli animali: un cane, gatti in libera circolazione e una capra bianca e nera. Alzavo la testa e vedevo lo spiraglio. Facevamo montaggi e lavori di carpenteria pesante. Cercava uno come me, capace di saldare. La saldatura l’ho vista fare in Libia. Osservavo e pensavo e imparavo. Con le parole ho provato a dire come si fa. L’ho detto tante volte, dentro il cubo. Ho vissuto di parole, nel cubo, con le spalle pressate dal metallo ruvido, il collo al limite del crac. Conoscevo bene il copione. Facile recitarlo e convincere quelli dell’agenzia. Mi era venuta a chiamare alle panchine del parco vicino al loro ufficio, una di loro. Non avevo risposto al telefono e da loro ero passato qualche giorno prima. Erano gentili. Più delle assistenti sociali che avevo conosciuto durante la breve accoglienza. Non avevo mai saldato prima di allora. Dentro l’officina, con il cannello in mano ho guardato il capo e gli ho detto: non mi ricordo, mi trema la mano: l’ultima volta l’ho fatto in Libia. Lui non ha capito le parole ma ha visto l’emozione. Ha calato la maschera sugli occhi bagnati. Ha avvicinato il cannello al metallo e ha spruzzato intorno i coriandoli di fuoco della saldatura. Lavorava da solo, nella lussuosa sfacciataggine del libero pensiero. Che non esprimeva con le parole. Ma con le azioni, i gesti.
La dignità del lavoro.
Mi ha insegnato, ho imparato. La fabbrica si è fermata quando il mondo di fuori, quello delle banche, ha esondato buttando i detriti della crisi finanziaria sull’economia. E sui lavoratori.
Non ho trovato un altro cubo aperto. Ho studiato le parole di un altro mestiere.
La sopravvivenza è una professione. Si impara. Ma non è per tutti. La competizione è vigliacca. Feroce. Poche volte stupisce per umanità.
Chi sopravvive non ritorna dentro il cubo, alla vita regolare.
Prima si perde il lavoro e al lavoro si può ritornare. Poi si perde la casa e si finisce in strada, ma dalla strada è difficile ritornare dall’altra parte del muro.
Ancora questo bambino vecchio con l’orecchino, qui e adesso.
Il freddo si stempera, ma le dita sono ancora rigide. La plastica dello sportello del parchimetro le taglia. Da quando si usa il bancomat rimangono poche monete. Allungare la mano davanti ai supermercati è senza risultato. Forse tutte queste persone davvero non hanno soldi spiccioli.
Hanno poco più di me, di noi inquilini della strada, ospiti delle arcate dei ponti: dormono.
Nelle stazioni ci sono sedie di forma slanciata per aiutare lo scatto della partenza quando la voce dice che il treno è in partenza. Finito il tempo del tepore dei listelli di legno e delle forme arrotondate delle grandi panchine dentro le sale d’aspetto nelle stazioni della ferrovia.
Dormire è impossibile. Senza sonno il freddo rompe le ossa.
Il bambino vecchio infila le dita nello sportello. Non ci sono monete. Le mani sono fredde e la plastica è dura.
Rompe lo sportello di plastica con le mani e scuote il parchimetro.
Lavoro, lavoro, lavoro a tempo indeterminato, lavoro sicurezza, lavoro soldi, lavoro millenovecento euro al mese, lavoro, lavoro, dammi lavoro.
Lo guardo. Mi avvicino e gli cingo le spalle. Un altro che vive fuori gli toglie la mano dallo sportello di plastica. Lui scalcia. Urla sempre la stessa cosa per interminabili minuti. Non siamo soli. Siamo osservati da uno squadrone di curiosi che stanno andando verso i treni. Altrimenti, lo avremmo portato al nostro ospedale da campo, il parcheggio mai terminato sulla tangenziale con grandi finestre aperte sul mondo. Ci ritiriamo là dentro quando dobbiamo curare qualcuno. Qui siamo controllati da questo gruppo che non se va. Chiamiamo l’ambulanza. Arrivano, lo caricano, strepita. Lo raggiungiamo all’ospedale. Sono un amico, dichiaro, un amico di Azad. Lui vaneggia. Parole senza senso. Quelle più frequenti sono: soldi, lavoro. Arriva un camice bianco e gli fa una puntura. Abbiamo parlato con il suo medico, dice. Azad è scompensato: è fuori di testa. Lo dimettono dopo l’ago nel braccio. Lo portiamo all’ospedale della strada. Lo spingiamo su per le rampe in salita. Fatica a camminare. Si stende su uno dei materassini appoggiati sul cemento. Il liquido del dottore gli è entrato in corpo. Lo sguardo è ritornato fisso e la schiena rigida. Parliamo per tutta la notte.
Il cielo freddo si intrufola nel cemento.
Il minaccioso murales di fuori controlla che nessuno disturbi. Ride e parla. Nel suo Paese aiutava un austista a truffare i turisti. Lestofanti alla ricerca di soldi: si fingevano taxisti e simulavano guasti dell’automobile e difficoltà improbabili per estorcere denaro. Era facile. Racconta e ride. Sembra uscito dal torpore della puntura. Non pensava fosse così difficile truffare gli italiani in Italia. Gli era riuscito molte volte nell’umidità appiccicosa del suo Paese. Credeva di essere un esperto. Lo ascolto. Vorrei scaraventarlo giù dal finestrone di questo parcheggio abbandonato. In tasca ho un rotolo di contanti sufficienti per potergli pagare un biglietto aereo di ritorno al suo Paese. Inquina la strada. Domani lo imbarco.
Questo ospedale da campo è un luogo pulito.
Da qui se ne è andato Paco, il vecchio cileno. Che mi ha lasciato in eredità l’incubo del cubo. In Libia io non sono mai stato dentro il cubo.
Qui, Paco mi ha consegnato la sua memoria di dolore.
Nel nome di Paco, in questa notte nera te ne vai da questo Paese.
Per mano di uno straniero fuori dal muro. Parola di Robile.
Quando non arriva la legge dello Stato, colpisce la legge della strada.