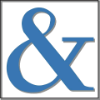In Libia si cessa di essere giovani.
In Africa l’infanzia è incarcerata in un tempo ristretto. Sulle carrette del mare il futuro vagisce e rantola insieme. Si dimena e rotola pericolosamente, rotondo come un dubbio.
Della Libia non si parla più. Superato il confine del mare. La Libia è il collo di bottiglia di tutto ciò che è stato prima: partenza, deserto, resistenza al sonno, alle botte, al viaggio. Hai bisogno del gruppo ma non ti puoi fidare.
In Europa si arriva da vecchi, anche se si è ancora ragazzi.
Ha cercato la costa libica. E’ andato dall’altra parte. Temeva di essere braccato via terra. Voleva vedere la Libia, incontrare quelli che arrivano dai Paesi a sud del deserto. Paura e curiosità hanno dettato il tragitto.
Poi ha avuto paura del mare. Montagne di stracci umani: corpi, urla, la pericolosa vicinanza, braccia che trattengono dallo scivolare via oppure spingono verso l’abisso.
Negli spostamenti di terra, lo spazio vitale permette di intuire vie di fuga. A piedi fino al nord, a volte nei brandelli di spazio dei Tir. Vigile anche se in sonno. Da allora non ha più dormito.
Il corpo non dimentica la paura.
Mette i piedi a terra e la bicicletta rallenta. A sinistra il corso d’acqua e a destra un fiume di persone. Sul naviglio pedala controcorrente. Si ferma. Secondo il navigatore la destinazione è a qualche minuto sulla destra. Strade affollate.
Si viene fin qui per sconfiggere l’inquietudine.
Chi ha intravisto frammenti di Europa, crede che il cuore della vita batta da un’altra parte. E che tutto sia possibile.
Osserva. Pedala da solo.
Una fiumana di umanità riposata cammina in file irregolari. Lo urtano, guardano avanti senza vedere.
Le ragazze hanno capelli liberi. Anche gli uomini: chiome curate.
Il ciclista scende, carica la bicicletta e si sposta fino al parapetto del naviglio. Si toglie il cubo dalle spalle, si siede sul muretto. Guarda la gente che passa, osserva le facce, i vestiti. Quelli più alla moda sono gli africani. Si notano. Nei loro occhi cerca la Libia. Non la trova negli sguardi velati dal fumo delle sigarette elettroniche. Forse sono nati qui
African time: si sfugge dal tempo africano, quando ci si avventura nel braccio di mare. Si cerca di svicolare dall’indolenza.
Sui navigli, si cammina velocemente. E’ una passerella di look costruiti. Una mostra di movenze e atteggiamenti. Lo sguardo puntato diritto quasi fosse la canna di un fucile con un mirino di precisione, senza vedere. Un brusio di confidenze e di parole, senza che nessuno ascolti.
Sono giovani anche gli anziani.
L’Africa è inquieta. Un continente abbandonato. Dopo avere simulato l’illusione di un cambiamento radicale, i colonizzatori hanno voluto inoculare la democrazia. Che ha evocato dal centro della terra i fantasmi del passato remoto: vecchi riti, antiche paura, gli dei dell’oltretomba. Poi sono ritornati, gli occidentali, come investitori.
Lo guardano tutti dai finestrini della corsa del sabato sera: è fermo, appoggiato al muretto del naviglio, il cubo appoggiato a terra, la bicicletta piegata in due alla sua sinistra. Ha ripreso a fare il lavoro che faceva in Iran: il giornalista. Ha la pelle olivastra e gli occhiali con una montatura quadrata. E’ magro e indossa scarpe da tennis, una giacca blu e un cappellino. E’ uno di loro al lavoro in un giorno di festa, un lavoro che conoscono: una possibilità di guadagno senza eccessivo investimento nel presente e senza ipoteche future.
Si attraversano terra e mare alla ricerca di un’altra vita, quella vera. Non si pensa al lavoro. Solo ad andare via, qualunque cosa comporti. Gli uomini vogliono dominare il tempo spostandosi nello spazio.
Scrivere un’altra Storia.
Seduce, la leggerezza di un nuovo inizio.
Se non fosse così si avrebbe paura del mare. Di finire nell’abisso oppure nell’inferno della tratta.
Squilla il telefono: dove sei, non sei ancora arrivato? Qui, abbiamo altre consegne. E’ più agitato del solito. E’ la prima volta che lo sente ruvido. Dal tono, adesso, capisce che Swen è il suo capo. Ha la sua età, ma lui è ancora giovane.
Ha accettato questo lavoro perché dopo la Libia non vuole più avere un capo. In Libia era lo schiavo del capo. Si doveva pagare ogni cosa con il lavoro. Il transito da un villaggio all’altro, il passaggio verso il mare, il passaggio attraverso il mare, il cibo. Dormire.
Finiti i soldi di casa, rimanevano le braccia.
Lo credeva amico, Swen. Uno che lo fa lavorare, che gli ha dato un contratto di lavoro. Il telefono, il cubo, la bicicletta parcheggiata: guarda lo schermo e vede che la destinazione è molto vicina. Lo paga regolarmente e gli invia la busta paga.
Ma lui vuole guardare il mondo. E non vuole avere un capo. Ha scelto quel lavoro perché pedalare rende liberi. Liberi di spostarsi. Di osservare.
Le ragazze hanno gambe lunghe e capelli senza censure. Hanno il volto aperto e camminano sicure con altre ragazze e con ragazzi con vestiti nuovi e strani.
Nel suo Paese non si può camminare da liberi verso un futuro libero. Le ragazze devono tenere la testa coperta e bassa. Lui lo ha detto. Il suo giornale non è così importante, ma lo ha scolpito sulla carta. Le donne non possono librare i pensieri: non possono sciogliere i capelli dal nodo del velo. Da lontano ha scritto delle ferite dell’Africa. Degli affari sporchi che fanno male all’Africa.
Ancora il telefono. Non ha consegnato, il cliente si lamenta.
Lo ha incontrato per la prima volta, Swen, su un tavolo chiaro di teak completamente vuoto. Intorno, altre scrivanie identiche alla sua con altre persone che non si conoscevano. Uno spazio per il co-working: gli ha spiegato. La nostra è una società smart che ha bisogno di persone giovani con voglia di fare e di costruire un futuro. Lui non gli ha detto che in Libia ha smesso di essere giovane. E neanche di avere perduto l’idea di futuro. Compare ancora il nome sul telefono in modalità silenziosa.
Chiude gli occhi quando squilla il passato.
Ti facciamo diventare una donna. Potrai manifestare con le donne e toglierti il velo. E scrivere da donna che le donne non possono sciogliere i capelli dal nodo del velo. Non è più andato a casa da allora. Lo hanno minacciato ancora al telefono. Sono andati a cercarlo a casa. I genitori lo hanno rinnegato. Sono stati obbligati per non essere uccisi. Si è nascosto a casa di un compagno dei tempi dell’Università. Ha racimolato denaro e si è messo in cammino. Ha chiuso il telefono. L’amico ha portato sue notizie ai genitori. E lo ha spinto verso il nord.
Mutilarlo per farlo diventare una donna significava tagliargli le mani, rompergli le corde vocali.
Annullare il diritto di parola.
Il telefono vibra in silenzio. Sono davanti al numero civico. Ma non risponde nessuno. Silenzio dall’altra parte. La sua posizione è tracciata. Lui è ancora seduto sul muretto del naviglio a guardare il passeggio dei ragazzi della sua età. Ha aperto il cubo e sta mangiando un panino con le verdure e il formaggio. Questo capo non lo picchierà. La cosa peggiore che possa fare è di non chiamarlo più al lavoro.
La busta paga ricevuta non è una busta paga. E’ una fattura. Glielo ha detto un conoscente. Il commercialista della società ha aperto per lui una partita Iva. Dovrà pagare altre tasse. Non è importante. Pensava di avere un contratto di lavoro, invece è un libero professionista. Lavoratore dipendente dalle telefonate del capo Swen. Neanche di lui ci si può fidare. E’ la stessa legge delle carrette del mare. Sulla terraferma si sopravvive in modo diverso.
La vita del corpo non è una garanzia per quella della mente.
Nessuno lo bastona, qui. Nessuna minaccia.
Lui entra nelle case. Suona il campanello, consegna pizze, piatti di gastronomia, farmaci, dolci. Vede ambienti e facce dentro le case, incontra animali e uomini. Ogni volta si chiede se appartengano allo stesso genere umano di quelli che lo volevano fare diventare donna con il cutter.
Non ricevere commissioni non lo spaventa.
In Libia la paura delle botte assedia lo stomaco. Non era bravo con i lavori manuali. Ogni volta che si avvicinava il capo, gli vibrava il cuore. In attesa di una bastonata sulla schiena. Qualche volta non arrivava. Ma quando arrivava il rimbombo rimaneva impresso nella memoria del corpo e della pelle.
Non si inganna il corpo. A lungo la pelle trattiene la memoria.
Il corpo è una macchina senza pezzi di ricambio.
Nel nord Europa non hanno creduto alla sua storia. Lo hanno ricacciato al sud. Dove ha raccontato di nuovo. E dove ha rifiutato il lavoro di fabbrica e tutto quello che si fa in gruppo. Nessuno ha capito la motivazione del rifiuto al lavoro.
Avrebbe voluto curare i vecchi. Perché loro conoscono il motivo di tanta violenza degli uomini contro gli uomini. Ma qualcuno gli ha detto che in avanzata età della ragione la degenerazione prende il sopravvento sull’obiettività.
E il suo interesse per i vecchi è svanito.
Ha continuato a pedalare. Nell’ossessiva ricerca di una motivazione negli anfratti della quotidianità di chi ordina la pizza. Scrive ogni dettaglio che vede. Nelle case calde e comode degli italiani. Descrive le infelicità nascoste nella facciata di plastica di esistenze recitate.
Nessuno ha capito la motivazione del rifiuto al lavoro.
Negare le parole è come uccidere.
Pedala da solo, Akthar. Scrive nella terra. Per sconfiggere i fantasmi della memoria.