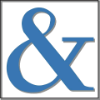Il mio tempo si è fermato indietro. Lontano. Ho paura del passato.
Non eravamo mai andati in bicicletta. Dove abitavamo tu ed io, io da sempre e tu da poco. Non è posto da bicicletta. Non per quelle di allora.
Qui, più a nord, le strade permettono di parlare pedalando.
Ci siamo conosciuti così, in Svizzera.
Tu hai imparato subito a mantenere il controllo della bicicletta. Cavalcavi senza sella, da bambino. In discesa senza toccare i freni e i tuoi canti caldi in una lingua rotonda. Hai imparato anche la lingua diretta e dura di qui.
Eri abituato alle lunghe distanze. Una migrazione dopo l’altra.
Ci pagavano bene. Noi lo credevamo. Per gli svizzeri eravamo mano d’opera a basso costo. Venivamo dal sud. Ma era un sud accettabile: il nord Italia per loro era il sud del nord. Il sud del sud, il mezzogiorno, era considerato terzo mondo.
La guerra era finita da tempo. Ma avevamo ancora le bombe nelle orecchie. Eravamo giovani, volevamo vivere. Avevamo bisogno di lavorare. Da noi, solo macerie.
La Svizzera è stata una lunga vacanza retribuita bene. Dal punto di vista di una povertà affamata. Durante la guerra, loro erano rimasti a guardare. La ripresa è stata più forte, ad artiglieria spenta. Per gli svizzeri, eravamo sudditi. Quando ci assumevamo a casa loro per i lavori domestici si sforzavano di dirci qualche parola.
Non ci guardavano, ci annusavano.
Siamo partiti tutti insieme, alla spicciolata. Uno aspettava l’altro, in una staffetta di attesa e di affetto per sconfiggere la paura. La paura dello straniero. Nelle fabbriche il padrone era il padre-padrone di tutti. Arrivava con i soldi. Li arrotolava tra le dita nello sfilarli. Una prestidigitazione. Quasi li volesse fare tornare indietro. Si fermava il respiro, in un battito, a ciascuno di noi.
Avevi un blocconote. Scrivevi il numero di ore lavorate, qualche nota sul lavoro svolto, osservazioni sui possibili miglioramenti. Idee. Eri l’unico a scrivere. Forse l’unico a sapere scrivere. I compagni di squadra ridevano.
Non avevamo libertà di movimento, da un cantone all’altro. Tanto meno da una fabbrica all’altra. Potevamo lavorare solo per il padrone che aveva firmato un contratto con noi e per noi. Il padrone poteva licenziare con un preavviso di ventiquattro ore. Le famiglie non potevano venire a trovarci. Noi avevamo paura di loro. Di quella lingua dura e strana. Di quegli occhi di ghiaccio affilato.
Ma avevamo la forza del futuro.
Tu hai imparato a fare un lavoro difficile. Eri osservato con interesse dal padrone. Con invidia dagli italiani. Guadagnavi come loro. Nessuno lo credeva. Tutti ti pensavano spia del padrone. Non si fidavano di te. Tu eri quello arrivato da fuori: occhi mobili e cervello veloce. Nessuna paura per uno spostamento di qualche centinaio di chilometri per uno abituato a cavalcare allo sfinimento.
Noi, invece, avevamo paura di tutto. Di dire le cose. Di sentire la nostra lingua incerta abituata solo al dialetto locale.
Dal lunedì al venerdì: la fabbrica. Il sabato e la domenica, tu ed io. Per i monti in bicicletta. Con i tuoi occhi nomadi sognavo spazi senza confini.
Il cielo pennellato sull’erba.
Sotto il tavolo, questa notte ho rivisto il cavallo.
E’ ritornata la grande macchina nera, con i vetri grigi, alta e lenta che oltrepassa il confine, verso l’Italia. Marcia a velocità bassa.
In un solitario e silenzioso corteo senza corteo.
Guadagnavamo soldi. Lavoravamo fino all’ultimo battito di stanchezza. Non eravamo amici. Tra di noi, molte parole sibilate. Tu eri un uomo solo nella tua diversità, per il doppio passaporto, per il mondo che avevi già visto. E perché non avevi paura. Per la tua condizione di figlio di una donna senza timori reverenziali.
Un nobile senza titolo con lo stile della sua classe sociale. Che lavora con le mani.
Un lavoratore che parla con il padrone. Per dirgli le cose. Per chiedere. Per ottenere. Hai chiesto sicurezza e soldi per tutti. La squadra aspettava di vedere il risultato. Prima di dire da che parte stava.
Solo dopo ti chiamavano fratello.
Vediamo se lo licenzia, l’argentino. Aspettiamo. L’argentino ha vinto. Senza alzare la voce. Eri tranquillo. Parlavi con lo svizzero nella sua lingua.
Del nostro gruppo, nessuno degli uomini sapeva lavorare con le macchine. Io facevo la domestica e per me è stato più facile. Ma gli uomini, hanno dovuto imparare a stare attenti alle macchine, a stare lontani dalle macchine, ad entrare in contatto con le macchine. Erano tutti agricoltori, abituati ai grandi animali, che non trattavano bene.
In Svizzera, in fabbrica, gli uomini hanno imparato il valore dell’attenzione.
Quando ho aperto gli occhi, questa mattina, ho visto il tavolo sulla testa. Ho alzato le mani e ho pensato che per me fosse finita. E in quel momento l’automobile, alta e nera, ha rallentato e mi è sembrato di vedere un’ombra dall’altra parte del finestrino.
Era una mattina di sole freddo. Quando una delle macchine dell’officina si era fermata senza bloccarsi veramente. Ma fingendo di volere ripartire. Tutti si sono guardati e ti hanno cercato. Hai messo mani e braccia nella macchina nel tentativo di rimetterla in guida. La macchina non te lo ha permesso. Ha aumentato la velocità del rullo e ti ha trascinato. Gli italiani si sono allontanati tutti. La macchina ha ruggito. E ha divorato il tuo silenzio incredulo.
Tu hai rivisto il cavallo nero impazzito che cercava di liberarsi da te e sapevi di farcela. Ma la macchina non aveva l’anima del cavallo e ti ha disarcionato.
Un corpo riverso a terra, torturato dalla meccanica.
Il padrone si è inginocchiato. La testa fra le mani. Ha pianto. Sul tuo corpo. Ha messo le mani nel sangue. Ha pianto per il figlio generoso e sveglio mai nato, per l’invidia verso quel padre che forse non aveva mai conosciuto quel giovane uomo biondo come il sole e forte come il fuoco.
Ha pianto per paura di perdere tutto: la fabbrica, il lavoro, i soldi.
Poi è arrivata la gendarmeria, il medico. I portantini ti hanno fatto scomparire.
Il lavoro sporco lo ha fatto la tua squadra. Gli italiani hanno pulito il pavimento dell’officina. Lo hanno fatto subito. Nessuno lo aveva chiesto.
Pagati per essere sudditi.
Uno sporco servo è servo per sempre.
Gli italiani hanno detto di non avere visto l’argentino al lavoro, quel giorno.
Di notte, in quella lunga notte, ho pensato di pedalare fino a Zurigo e di buttarmi nel lago freddo.
Il padrone ha chiamato gli operai italiani. Il sudamericano non sapeva fare bene il lavoro. E’ per questo che ha sbagliato. La macchina era vecchia e la manutenzione non la facevano da tempo. Tu lo sapevi. Ma lui non lo ha detto. Il padrone ha pianto. Ha fatto un giro intorno al cerchio di uomini e ha sfilato le banconote dal rotolo, una alla volta, una grossa banconota.
Questa volta non ha fatto la prestidigitazione.
Gli uomini hanno preso la banconota, l’hanno infilata in tasca e hanno serrato le mani. E il gruppo si è sciolto.
Il padrone ha scritto un telegramma alla madre. Le ha detto che il suo ragazzo è caduto in una strada di campagna, durante una passeggiata in bicicletta, e ha battuto la testa. Le ha scritto che i compagni di lavoro hanno raccolto i soldi per il trasporto e per il funerale e che lui, come padrone, aggiungerà una somma per rendere dignitoso l’ultimo viaggio.
Poi il padrone ha chiamato me.
Mi ha strusciato la guancia con la mano molle e viscida di chi non lavora. Mi ha detto: sei giovane, meriti il futuro. Avevo ancora indosso il grembiule dei lavori domestici e mi ha infilato nella tasca due grandi banconote. Ha continuato a toccarmi la faccia con la mano aperta, poi mi ha messo le mani nel collo e mi ha avvicinato.
L’ho strattonato, l’ho spinto. Sono scappata via.
Ero agitata. La padrona mi ha fatto sedere in cucina e mi ha dato una tazza di latte caldo. Domani me ne vado, le ho detto. Se vuole mi paga e non vuole faccia come crede.
Non avevo mai viaggiato da sola. In treno.
Sono tornata. Nessuno mi aspettava, nessuno lo voleva il mio ritorno.
Tu sei tornato con la grande macchina nera dopo qualche giorno. Ricomposto dentro una bara di legno chiaro con fiori bianchi sul coperchio.
Rinchiuso per sempre.
Mi capita spesso di finire sotto il tavolo, di notte.
La sera prima del funerale sono andata nella tua casa di sasso con il tetto a capanna. Ha tardato ad aprire, tua madre. Era diventata una vecchia con la faccia da strega, occhiaia nere e una sigaretta arrotolata in una carta leggera e bianca costellata di parole. In faccia una cartina geografica di rughe. Scomparsi gli occhi di ghiaccio, intrappolati tra la piaghe della pelle. Non l’avevo mai vista fumare. Ha presidiato l’ingresso. Stivali, pantaloni e casacca, gambe divaricate e un braccio appoggiato a un fianco. Dentro, sul tavolo disadorno: una lampada a olio, un grande libro aperto, forse la Bibbia e accanto una pistola.
Vattene, ha ringhiato imponendo le mani ossute.
Il giorno del funerale non ha permesso a nessuno di entrare in chiesa.
A pugni di terra, ha coperto la bara fino a farla scomparire.
Poi si è ritirata nel silenzio del tempo venuto dopo. In compagnia di un lupo al quale era morta la madre, si dice.
Gli uomini della squadra ritornano qui qualche volta.
Sempre gli stessi. Gregari come allora.
Non hanno mai cercato tua madre. Neanche me, Catalina.
I gregari non guardano in faccia chi ha lo sguardo diritto.
La colpa è una lapide. Che opprime la memoria incarcerata.