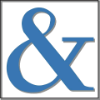Una macchia di nero in un gruppo di visi pallidi.
Spiccano i denti, bianchi come il camice fino a che non si macchia di rosso. E’ l’unico africano, anzi il primo della fabbrica. I colleghi lo vivisezionano.
Il capo turno lo affida a un rumeno, per qualche ora alla cernita e allo spazzolatura delle buste che contengono la polpa di pomodoro.
Poi lo sposta con una delle operaie più anziane di esperienza alla macchina del riempimento lattine. La donna è scattante e piccola, un’italiana del sud ma non siciliana. Il pomodoro caldo arriva dalle bocchette posizionate in alto. Il nero e la donna del mezzogiorno devono infilare le lattine sotto il getto rosso. La collega mette le lattine al contrario, con la base del cilindro in alto. Il pomodoro schizza dappertutto. In poche ore alle buste, lui ha capito che gli operai si coprono a vicenda, che il gruppo è un corpo unico. Lo hanno osservato in silenzio e gli hanno detto poche parole.
Uno che attraversa il mare su una carriola di corpi impara presto a capire l’umore del gruppo. E a sapere che cosa si possa fare e per che cosa si possa morire.
Osserva il pomodoro schizzare via dalla base delle lattine rovesciate. Guarda la collega che continua a mettere i contenitori nella stessa posizione. Lui fa esattamente la stessa cosa.
Il pavimento si trasforma in una pianura di melma scivolosa. Le bocchette continuano a sputare fuori il getto caldo della passata di pomodoro e loro continuano a posizionare le lattine al contrario.
Il vulcano sputa la lava e loro non si spostano.
Il capoturno tuona contro di loro, interrompe il flusso, ferma la macchina. Inveisce contro l’operaia. Urla contro di lui. L’operaia guarda il nero, il nuovo arrivato.
Il capoturno guarda il nero e gli chiede se ha una testa sulle spalle, se capisca l’italiano.
Il nero arrossisce sotto il nero della pelle. Fagocita la saliva.
Prende la voce che gli è rimasta e sibila che è solo il suo primo giorno di lavoro e ha sbagliato e si scusa ed è a disposizione per pulire il pavimento. L’operaia riprende il lavoro mentre il nero pulisce il pavimento per lei e per lui.
L’operaio nero sa di avere superato la prima prova. Non ha fatto la spia. La donna- uomo, l’operaia più anziana, passa dal reparto mentre lui pulisce il pavimento e gli dice: bravo, sei uno di noi.
Il gruppo è composto da operai rumeni, moldavi e italiani. Gli italiani sono in maggioranza. Si assumono tra di loro, attraverso un tam tam all’esterno della fabbrica. Quando qualcuno se ne va, sono più veloci dell’agenzia a trovare un sostituto. E’ una catena solidale e familiare, partita con l’assunzione delle persone più vicine per poi allentare la parentela e arrivare ai conoscenti.
Lui, il nero, è un incidente di percorso. Hanno riempito la fabbrica con amici e parenti. Per la nuova posizione non hanno trovato nessuno. L’agenzia ha proposto il candidato nero. Che ha fatto un buon colloquio: ha firmato il contratto al pomeriggio e cominciato il lavoro di notte.
Dopo l’incidente delle lattine, lo hanno invitato qualche volta alla macchinetta del caffè durante la pausa lunga.
E’ amichevole con loro ma è sempre all’erta. Ha ancora il barcone di disperati in testa: la sua palestra di sopravvivenza.
Di notte, circola cibo. Arriva qualcuno con grandi pezzi di formaggio oppure con lattine di pomodoro. A turno, infilano le cose negli zaini. Di notte, le pause per la sigaretta e per il bagno sono più lunghe. Tutti vedono, nessuno dice. Di notte se una macchina inciampa, la si ferma. Il manutentore arriva lentamente e con attenzione la ripara e la fa ripartire. Qualche volta ha portato a casa il formaggio anche lui. Temeva che qualcuno lo fermasse all’uscita. Nel caso di un fermo per controllo, all’uscita dai tornelli, l’accordo è: silenzio qualunque cosa accada: ho preso la merce perché sono in difficoltà economica.
Di notte il rumore ha il volume basso.
Lui lavora, aiuta gli altri e parla poco. Non vede che cosa succede.
Alla fine del breve contratto, il capo turno lo ha chiamato e gli ha chiesto del turno di notte. La notte è dura, ha detto lui. Il capo turno gli ha chiesto se i bianchi lo abbiano per caso discriminato. Gli chiede se ha visto cose strane.
Il nero ha roteato gli occhi e gli ha detto che, no, non ha visto niente.
Il capo gli ha sparato addosso occhi vitrei. Perché abbassi lo sguardo, gli ha chiesto. E’ la mia cultura, ha risposto. Non si guarda in faccia chi ti dà da vivere.
Il capo è più giovane di lui, ma comanda. E non si sporca di pomodoro. Tarchiato, pelato, se ne è andato a gambe larghe per il corridoio centrale del grande magazzino. Ha guardato a sinistra, si è fermato ad osservare la scaffalatura di destra.
Non si ruba solo in produzione. Si ruba dappertutto. Si fanno sparire grandi pezzi di formaggio, di notte, in produzione. Di giorno, le lattine di polpa di pomodoro, le scatolette di tonno e tutto ciò che è possibile. La prendono dal magazzino. Sbucciano i bancali e riempiono gli zaini. Gli stipendi sono bassi per tutti. Si ruba per non fare la spesa al supermercato.
Ciascuno pensa a sopravvivere, giorno per giorno. Io vivo, l’azienda muore.
All’interno del gruppo ci si alterna, a prendere il cibo e a portarlo via. Qualcuno lo rivende all’esterno.
Le guardie ne hanno fermati due. Un italiano e uno straniero: la povertà ha lo stesso colore in tutto il mondo. Li hanno chiamati in ufficio il giorno dopo. Hanno ricevuto un richiamo. Li hanno sospesi. E’ arrivato un sindacalista. E il lavoro è aumentato per quelli rimasti. Anche i controlli.
Il nero è andato dal capo e ha proposto un amico. E’ entrato il secondo nero in fabbrica. Poi il secondo nero ne ha fatto entrare un altro. E un altro ancora. E lui non è solo.
Intanto, il capo gli ha chiesto se abbia visto cose strane. Il nero ha risposto: no, non ho visto niente. Ma che tipo di cose strane? Forse rubare? Hanno sparato fuori gli occhi vitrei. Il nero ha alzato gli occhi e gli ha chiesto: che cosa mi dai? Ha sentito il freddo del mare di nuovo, quasi un avvertimento.
Il capo non ha risposto. Il nero ha detto senza dire.
I furti si sono fermati per qualche settimana. Poi qualcuno ha ricominciato. La produzione ha rallentato, la notte. I film termoretraibili, nel magazzino, strappati durante il giorno.
Il tarchiato ha chiamato il nero in ufficio. Questa volta non ha visto proprio niente. Il tuo contratto è in scadenza, gli ha detto il capo. Il nero ha pensato alla famiglia, giù in Africa. E al debito del viaggio che deve ancora saldare. Non ha visto questa volta ma ha visto prima.
Qualcosa ho visto, ha detto. Ha abbassato gli occhi e ha sibilato qualcosa dei furti in produzione, i chilogrammi di formaggio grana di notte. Il capo si è seduto e gli ha chiesto i dettagli. E lui ha detto dell’alternarsi degli autori dei furti. E della consegna del silenzio.
Le guardie di notte sono raddoppiate, dopo che il nero è andato in ufficio. I capo turno controllano anche i minuti delle pause. E’ finita l’autogestione. Qualcuno tiene nota del tempo di lavoro, conta i bancali. I flussi produttivi sono controllati a vista, tracciati con carta e penna. Sono arrivate le telecamere in produzione. Forse è troppo tardi. La fabbrica è in affanno.
Eppure si ruba ancora. Il bilancio è un colabrodo.
Va male da quando sono cominciati i controlli. I controlli sono cominciati dopo che il nero è andato in ufficio. I neri lavorano senza parlare. I visi pallidi sono tutti all’erta.
Lo hanno accerchiato, di notte, nel piazzale di fuori. Il passamontagna, sulla faccia di ciascuno. Senza parlare, ma riconoscibili. Perché i corpi non si cancellano. Pugni e calci in una gragnola di colpi mitragliati fuori da una rabbia senza pudore. E’ rimasto a terra, ammaccato nell’orgoglio. Ha sperato di essere buttato in mare, di affondare fino in fondo. Di purificare la colpa nel freddo del profondo. Ha bagnato i pantaloni, si è sporcato come un bambino, i capelli invischiati di sangue, la testa rotta. E’ rimasto a terra per ore, mentre gli operai a fine turno se ne andavano. Nessuno si è fermato, nessuno ha visto. Dopo ore si è trascinato fino al fosso dove scarica la fabbrica. Si è rimesso in piedi, in un equilibrio precario. Se ne è andato via spingendo il motorino a mano. Ha strisciato i piedi per la lunga strada di periferia dove le auto sfrecciano come se fossero in autostrada.
Non lo chiama il capo, non lo chiamano gli africani che ha presentato. Nessuno lo chiama. E’ rimasto a letto a sperare di morire, prima di andare a chiedere soccorso.
Un avvocato è come un prete. La differenza è che l’avvocato non vuole sapere se hai commesso il reato. Lo paghi, ti difende e basta. Non giudica. I soldi annullano il giudizio. All’avvocato dici di te anche le cose che non c’entrano con il fatto.
Umanità e onestà non sono della stessa razza. Gli uomini non possono essere onesti.
I furti non si sono fermati. I visi pallidi hanno ripreso a rubare. Gli africani non hanno smesso. Lo fanno in modo diverso.
L’onestà presuppone la perfezione. E gli uomini non lo sono.
Tutti colpevoli di essere gregari nell’imperfezione.
Spaventati dall’angoscia della fine, della quale ci si dimentica per sopravvivere.
L’illusione della costa, anche al centro del mare.
Chi sopravvive ha imparato a farlo. La pena da scontare è la colpa di avercela fatta. Chi sopravvive sa come respirare sott’acqua.
Fuori dalla fabbrica e fuori dalla vita, i fatti sono freddi.
L’africano ha un arto compromesso. Non può lavorare. Non più.
Non è sufficientemente invalido per avere una pensione.
Nessuna testimonianza a suo favore.
E’ un delatore. E’ una vittima di violenza.
Tutti colpevoli. Di essere poveri. Di avere perduto l’ultimo brandello di imperfetta umanità.