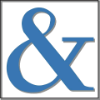Un abituro di fango a forma di cubo. Pioggia incessante di luglio. Una vita costretta. Infanzia senza corse. Sgrana gli occhi e fa il broncio perché la tristezza di tutti contagia anche lui. Vita in scatola. Morte e nascite si alternano in sequenza. In pochi sopravvivono. I matrimoni in famiglia sono una tradizione. Difficile sposare qualcuno da fuori. Nessuno arriva. Il mondo si è fermato nelle case sudate di terra. Non vedi il tempo futuro se non hai finestre. Il villaggio si moltiplica nella sequenza di matrimoni combinati fra parenti stretti. Si muore da piccoli. Il caldo è un caldo disperato. Il freddo, un trapano. Le difese immunitarie e il corpo non sono programmati per sopportare il caldo del sud e la lama del vento di montagna. L’eredità genetica è una zavorra e ricaccia i corpi sotto la terra. Chi rimane accetta l’Islam come regola di vita. Quello ruvido dell’Afghanistan castiga d’imperio la apparente fluidità della tradizione indi. Si vive con fatica. Morire è la norma. Chi se ne va raggiunge Islamabad, perché ha un parente, un conoscente con un’attività commerciale. E’ un circuito chiuso. Si diventa grandi in fretta e si è ancora bambini. Le case non sono solo fango. Le case dei signori hanno decorazioni, scritte accurate sul frontone, porte di pregio. Sono solide come l’economia domestica delle famiglie che le abitano. Chi ha soldi ha potere. Può studiare in un altro Paese. Può andarsene a cercare lavoro negli altri Paesi senza pagare i trafficanti. Per un bambino andare nella città vicina significa emigrare. E’ un salto nel cielo. A scuola studia come può e quando può. Il negozio del parente è una prova di mondo. Nella grande città si muore diversamente. Quelli che se ne vanno per malattia non si vedono. Ma si vedono le botte degli uomini contro gli uomini, per motivi di religione, di difesa del territorio e cioè del negozio, un fazzoletto di spazio dove ci si muove a fatica. Quando esplodono le bombe scuole e bazar si richiudono nell’ombra lunga della sera. Per nascondersi. Il tempo è immobile. Il mondo di Alì fino al 2019.
Andare per ricominciare.
La eco delle bombe sedimenta dentro le orecchie. Sempre sul punto di esplodere nel sonno. Anche se fuori è silenzio. Il bambino è un uomo, un giovane adulto pronto a prendersi il lavoro. Vuole perdere il ricordo delle esplosioni. Cancellare il pensiero delle morti dei fratelli addormentati e mai risorti. Teme l’insidia della malattia del corpo. Non considera la possibilità di una deflagrazione per effetto di una bomba. L’asolo di viaggio è romantico solo sui libri. Nei fatti è paura e pericolo. Il trafficante protegge in cambio di molti soldi, migliaia di euro, fino a che si è dall’altra parte del confine. Dove comincia la terra di nessuno. Dove si cammina fino a fare sanguinare i piedi per raggiungere una città dove sia possibile morire di fatica a costruire un grande centro commerciale.
Iran.
A Teheran il cemento è diventato una pelle spessa sopra le mani. Lo pagano meno, molto meno di un iraniano. Ma loro sono a casa loro e sono i padroni. Lui è un ospite. E ci sono altri confini da varcare. Altre dogane illegali da superare. Sette, otto mesi a Teheran. Il quartiere-ghetto dei migranti è affollato di afghani che considerano questa una terra promessa. Gli afghani con la loro matrice religiosa rigida rappresentano una presenza inquietante. Si è integrato nel buio della povertà della baraccopoli. Ma con sospetto. Lavora sempre di più per accelerare il tempo del distacco da quel gruppo.
Turchia.
La Turchia è la tappa successiva. Lavora in agricoltura. Il lavoro travolge la sua capacità fisica. Non cede la mente. Il corpo ansima. Altri mesi di disperazione. Ed è pronto per il passaggio verso la Bulgaria. Da uno spiazzo chiassoso di automobili grandi e impolverate con targhe austriache e tedesche si sconfina in terra bulgara. E’ un brulicare di tuniche islamiche e veli sudati a coprire i volti delle donne sedute accanto agli uomini alla guida. Il muezzin intona il richiamo da un altoparlante. La mezza luna da una parte. Gelo e silenzio dall’altra. Ed è come se sparisse il sole. Ma questo non è l’ovest. Questo è il sud est. Lui osserva i due lati del passaggio dal bosco diviso dal filo spinato. Prima o poi gli capiterà di attraversare una frontiera senza nascondersi, senza fuggire. Senza inspirare il sangue dal cuore.
Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia.
Un lungo vagabondaggio, con altri due, forse tre uomini a vista. Sono un gruppo e non si conoscono. Si osservano a distanza di sicurezza. Pronti a fuggire nella direzione opposta oppure ad acquattarsi nella vegetazione se uno di loro dovesse essere aggredito, catturato dagli uomini. Assalito da animali in cattività. I più pericolosi sono gli uomini contro gli uomini. Possono cambiare il segno dell’azione in un battito. Il clic di un’arma da fuoco. La pressione di una lama in profondità. Il bosco è magico e insicuro. Tra gli alberi e le foglie è un animale in fuga. Un cocktail impazzito di cortisolo e adrenalina. Sonno e veglia si alternano in modo casuale. La guida li abbandona alla solitudine una volta superato il confine e indica il percorso da tenere fino all’altra frontiera. Camminano e mangiano quello che trovano, erba o bacche. Si nascondono ad ogni minimo rumore. Si controllano l’un l’altro. Ma non si parlano. Fino al confine d’acqua. Non è Bulgaria, questa. Ma un altro tragitto.
Drina.
La Drina è un fiume autoritario, subdolo e violento. Nelle sacche di calma illude. Acque pesanti capaci di spostare i corpi. Che diventano duri come il marmo. Chi supera la Drina ha vinto il game. E’ quasi in Europa. Anche se il rischio di incontrare i bastoni e le lame che tagliano le scarpe rimane fino a Trieste. Le fabbriche abbandonate sono i dormitori dei migranti in transito, quelli che hanno scelto la via balcanica. Di cemento in cemento si entra in Italia. Dove i bastoni sono ancora bastoni ma è più facile trovare un tetto per una notte e una mano che ti porge una coperta alla stazione dei treni. Cemento e asfalto e verde bagnato del parco pubblico sono i giacigli.
Bosnia, Croazia, Slovenia.
Via dai campi greci. I Balcani: una scommessa di sopravvivenza. Non li conosceva prima. E neanche ora li conosce. I Balcani sono un giacimento di incognite. Una terra di luoghi oscuri. Un campo aperto dove si sta svegli anche dentro il sonno e a occhi chiusi. Fernetti, Trieste, Italia. Il viaggio di Alì dal 2019 al 2021.
La vita è ritornata dentro il cubo. Una giornata di lavoro per dormire fuori, durante la notte. Sul marciapiede con una coperta addosso. Niente bastonate, per ora. Il lavoro è arrivato subito. Un pakistano in stazione, parlando e parlando, gli ha detto di una fabbrica che paga per lavorare nel magazzino. Un lavoro pesante. Pagato bene. La lingua non serve. Importa scaricare i grandi pacchi di merci, usare un carrello per spostare bancali pesanti. Gli operai arrivano da tutto il mondo. In pochi parlano l’italiano. Gli ultimi che arrivano devono pagare quelli che li hanno portati alla fabbrica. Li devono pagare subito, all’inizio. E ogni volta che prendono lo stipendio. Non si sa quanto paghi ciascuno di loro e a chi paghi. Ma tutti pagano qualcuno. I soldi dati ai trafficanti sono serviti per attraversare i confini. Per pagare in nero l’ingresso, il visto. Non è rimasto niente. Una volta pagato per lavorare, qui invece qualche cosa rimane. Ed è sufficiente per fare vivere bene molte persone al Paese di origine. Costa molto trasferire soldi all’estero. Ma è il segnale che il lavoratore è arrivato. La prima settimana e il primo mese scivolano via. L’asfalto è duro ma di notte non è ancora freddo come nei Balcani. Come l’acqua della Drina. Un gruppo ha protestato per il lavoro. La fabbrica dovrebbe pagare di più. Più soldi e contratti più lunghi. Il contratto non sa che cosa sia. Gli hanno dato un foglio di carta scritto in italiano dopo un mese di lavoro e tutti i mesi versano i soldi sulla sua carta postale. Nella sua lingua gli hanno detto di andare tutti i giorni, anche il sabato. Poi gli hanno dato un altro foglio di carta con un’altra data e non ha più visto alcuni operai provenienti da un Paese diverso dal suo. Quelli l’italiano lo parlano e lo capiscono. Li ha visti in gruppo dentro la fabbrica. Li ha visti con le bandiere fuori dalla Prefettura. Poi non li ha più visti. E sono arrivati altri, nuovi. Che non parlano la lingua e lavorano male. Perché sono appena arrivati. Pensano di poter fare tutto solo perché hanno attraversato il mare. Dopo qualche mese di turni impazziti, giorno poi notte, poi pomeriggio poi notte, poi straordinari di notte, poi due turni di giorno, credeva di guadagnare di più. Le tasse. Puoi andare all’ospedale senza pagare qui perché paghiamo le tasse per te. Il corpo ha bisogno del cubo di casa. Per dormire e non risorgere. Gli hanno trovato una casa, un quadrato di pavimento per dormire in una stanza piena di persone sui letti e sui tappeti. E una cucina con un fornello a gas più affollata del bar della stazione ferroviaria di una grande città. Paga per lavorare e paga per il pavimento. Paga tutto: i turni in cucina, l’acqua della doccia, il letto se vuole dormire dopo un turno. Fine del viaggio. Dopo la Drina.
Dopo tre anni il lavoro continua. Gli operai si riuniscono ancora. E cambiano in continuazione. Ma lui resiste. Continua a mandare soldi a casa: le briciole che rimangono. Per loro sono tanti soldi. Lui ha vissuto in strada e ha vagato di pavimento in pavimento. Nel 2023 si è messo in società con un connazionale. Gestiscono un Internet Point e una postazione di Money Transfer. Un negozio, come quello del suo parente a Islamabad. Dormono nel negozio. Non pagano per dormire. Non è più una prova di mondo. Game over.